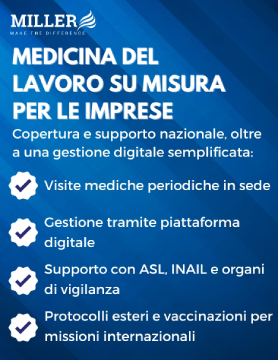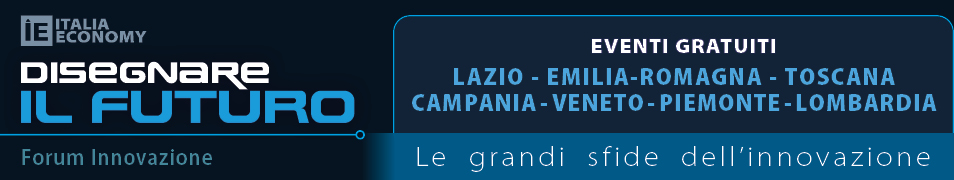Cooperativa di comunità I Briganti di Cerreto. Restare per rigenerare: la montagna come scelta di vita
Dalla forestazione al turismo di comunità, la cooperativa I Briganti di Cerreto racconta come si può abitare l’Appennino senza nostalgia, ma con un progetto condiviso. Ne abbiamo parlato con Erika Farina, socia fondatrice della cooperativa di comunità
«Siamo partiti nel 2003 con 100 euro a testa, un notaio e un’idea: non andarcene». La storia della cooperativa di comunità I Briganti di Cerreto comincia così, con un gruppo di giovani ventenni che sceglie di non abbandonare la montagna, ma di metterla al centro di un’impresa. Un gesto tutt’altro che romantico: «Volevamo invertire la rotta che avevano preso i nostri genitori e i nostri nonni, che dal crinale erano scesi a valle o in città in cerca di fortuna». Loro no. Hanno scelto di restare e vivere dove erano cresciuti, a Cerreto Alpi, sull’Appennino reggiano, un borgo che oggi conta una cinquantina di residenti stabili. Oggi la cooperativa conta nove dipendenti, tutti cresciuti insieme al progetto. Il primo è stato il fratello di Erika Farina, Luca, che ancora oggi ricopre il ruolo di presidente. Da un piccolo nucleo con una passione comune per il bosco – «eravamo montanari, cacciatori, fungaioli» – i Briganti di Cerreto hanno costruito un’impresa multifunzionale, capace di evolversi nel tempo ma sempre radicata nel territorio.
La sfida delle aree interne

Operare in un’area interna significa fare i conti con spopolamento, distanza dai servizi essenziali e difficoltà infrastrutturali. Ma anche con un senso di comunità che, se valorizzato, può diventare leva di sviluppo.
Lo testimonia il percorso recente della cooperativa, che ha partecipato a un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alle aree interne. Un’esperienza che ha segnato il primo passo nel campo del sociale per i Briganti di Cerreto, fino ad allora attivi principalmente nella forestazione, nei servizi agricoli e nella manutenzione del territorio (sfalcio erba, spalatura neve, gestione del verde). «Con questo progetto abbiamo fatto qualcosa di nuovo: ci siamo presi cura delle persone», spiega Erika Farina. La cooperativa ha acquistato un pulmino da nove posti e ha iniziato ad accompagnare gli anziani del paese alle visite mediche, a ritirare la pensione, a partecipare a momenti di socialità. «Abbiamo organizzato pomeriggi di aggregazione nelle varie municipalità, gestendo due centri di socialità. Il nostro obiettivo era ridurre il senso di solitudine che colpisce molte persone anziane che vivono sparse tra le frazioni. È stato faticoso, ma molto significativo. Ha ridato vita a legami che si stavano spezzando».
Un turismo che si fa relazione
Dalla cura del bosco a quella delle persone, il passo successivo è stato accogliere chi arriva da fuori. Ma sempre con lo stesso approccio: mettere al centro l’esperienza diretta, l’autenticità dei rapporti, la vita quotidiana. È così che nasce l’idea di “turismo di comunità”. «Le persone che vengono qui cercano qualcosa di vero. Non solo il paesaggio o il silenzio, ma soprattutto il rapporto umano. Vengono da turisti e ripartono da amici», racconta Farina. L’offerta turistica della cooperativa è costruita attorno ad alloggi diffusi nel borgo: un vecchio mulino, il pollaio della nonna, case restaurate nel rispetto della tradizione. Gli ospiti partecipano alla raccolta delle castagne, scoprono la seccatura, ritirano la farina prodotta. Parlano con gli anziani del paese, condividono momenti con i soci. «È un’esperienza concreta, diretta. Nessuna finzione scenica. È la vita com’è davvero, qui».
Restare per costruire comunità
 L’impatto del progetto va oltre il piano economico. Nove posti di lavoro in un paese di cinquanta abitanti significano famiglie che restano, bambini che crescono, scuole che restano aperte. «All’inizio eravamo ventenni, oggi abbiamo quarant’anni, figli adolescenti. Alcuni di noi erano andati via e sono tornati. Vivere qui non è facile, ma si può fare. E questa è già una risposta a chi pensa che la montagna sia destinata a morire».
L’impatto del progetto va oltre il piano economico. Nove posti di lavoro in un paese di cinquanta abitanti significano famiglie che restano, bambini che crescono, scuole che restano aperte. «All’inizio eravamo ventenni, oggi abbiamo quarant’anni, figli adolescenti. Alcuni di noi erano andati via e sono tornati. Vivere qui non è facile, ma si può fare. E questa è già una risposta a chi pensa che la montagna sia destinata a morire».
Il senso di appartenenza è il motore profondo che tiene insieme la cooperativa. «Abbiamo costruito le nostre vite qui. Non solo il lavoro, ma anche le relazioni, le famiglie, il tempo libero. Abbiamo provato a dimostrare che restare è una scelta possibile, non solo per chi è nato qui, ma anche per chi potrebbe decidere di venire a vivere su, anche da fuori».
Guardare avanti
La sfida oggi si gioca su nuovi fronti. La natalità è bassa – l’ultima bambina è nata sette anni fa – e l’invecchiamento della popolazione impone un’attenzione crescente ai bisogni sociali. Ma accanto all’assistenza agli anziani, la cooperativa guarda al futuro: coworking, smart working, rifugi multifunzionali, telemedicina. «Abbiamo avviato un progetto di ristrutturazione del nostro rifugio con fondi del PNRR. Vorremmo trasformarlo in uno spazio aperto, dove chi viene da fuori possa lavorare da remoto, organizzare attività, innamorarsi del paese. Ma per farlo servono infrastrutture adeguate. Non tanto strade, quanto connessione veloce: senza internet, il lavoro da remoto resta solo un’idea». Anche sul piano sociale, la cooperativa sta progettando nuovi servizi con il supporto di Legacoop. L’obiettivo è continuare a tenere insieme lavoro, comunità e territorio. «Siamo convinti della scelta che abbiamo fatto. La montagna è viva se le persone restano. E le persone restano se ci sono opportunità, relazioni, dignità. Questo è quello che proviamo a costruire, giorno dopo giorno».